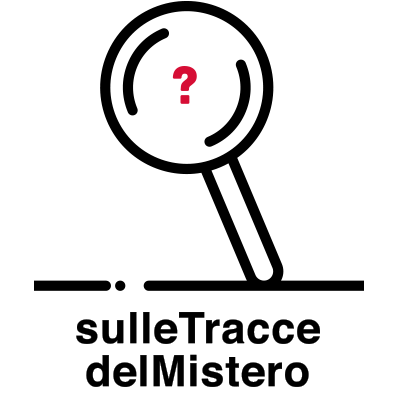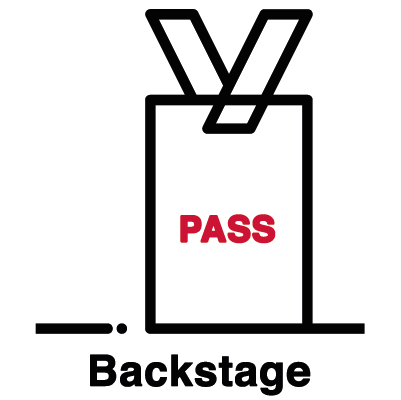Il Sestante – Migranti e populismi locali: se arriva l’ora di smascherare l’inutilità del cinismo
Homepage - A tal proposito, è con particolare attenzione che oggi guardo alla polemica sull'immigrazione in città, recentemente portata alla ribalta, tra gli altri, dal movimento civico di Chiara Frontini al grido di "Viterbo non è un albergo" insieme alla richiesta che, in tempo di crisi, i fondi pubblici destinati ai richiedenti protezione internazionale vengano invece destinati ai servizi per i cittadini.
Spesso, quando si pensa della dimensione locale, si è portati a credere che il compito degli enti più prossimi ai cittadini, primi tra tutti i Comuni, sia essenzialmente quello di gestire gli affari ordinari della vita di tutti i giorni, dalle buche alla segnaletica: è il livello che potremmo definire “delle piccole grandi cose”, perché comunque significative per ciascuno di noi.
Chiaramente, volendo alzare un po’ il tiro, ci si avvede che la realtà è assai più complessa perché gli enti locali, solo per fare alcuni esempi, partecipano anche alla pianificazione strategica territoriale (v. piani regolatori) e alla erogazione di prestazioni solidaristiche (v. servizi sociali): è il livello “del governo del territorio e del suo sviluppo socio-economico”, che risulta essenziale per la vita della comunità e che, proprio per questo, dovrebbe costituire il più concreto terreno di scontro tra le forze politiche.
D’altro canto, i Comuni possono essere molto di più. Infatti, essi divengono spesso la sede dove vengono dibattute questioni e lanciate iniziative politiche che, formalmente, esulano dai compiti amministrativi dell’ente, eppure, risultano particolarmente avvertite dalla popolazione: è il livello che potremmo denominare “dell’impulso al dibattito nazionale”, il quale risulta consustanziale alla natura democratica del Comune e che, anzi, dovrebbe denotare la vivacità del territorio inteso stavolta come “comunità delle idee”.
Ebbene, è esattamente su questo terzo livello che vorrei condividere con voi alcune riflessioni perché, a ben vedere, lo considero come un buon barometro dei tempi.
A tal proposito, è con particolare attenzione che oggi guardo alla polemica sull’immigrazione in città, recentemente portata alla ribalta, tra gli altri, dal movimento civico di Chiara Frontini al grido di “Viterbo non è un albergo” insieme alla richiesta che, in tempo di crisi, i fondi pubblici destinati ai richiedenti protezione internazionale vengano invece destinati ai servizi per i cittadini.
Ora, non è mia intenzione discutere sull’ “inutilità pratica” di un’iniziativa che esula dalle competenze comunali: come anticipavo, si tratta comunque di dare linfa a un dibattito pubblico, tra l’altro su un tema attuale e fortemente avvertito a livello locale e nazionale. Del resto, se vivessimo nell’Iperuranio platonico, nessuno potrebbe mettere in discussione la logica intrinseca dell’affermazione che, a fronte di risorse scarse astrattamente destinabili a usi alternativi, si impone una decisione sulla priorità nel loro impiego (anzi, è questa la definizione che Lionel Robbins diede di “economia”).
Tuttavia, siccome non viviamo in un universo metafisico, davvero pensiamo di poter far passare per “pragmatismo” quello che, semmai, rappresenta un “inutile cinismo”? Ora, si potrebbe ridere di chi considerava tra “le cose più sante” (allo stesso livello della triade “Dio, Patria e famiglia”) anche l'”Umanità” (Mazzini), magari accusandolo a posteriori di essere stato lui stesso un “benpensante”.
Del pari, si potrebbe bollare di sterile accademismo quella dogmatica che voleva nello Stato un ente “a fini generali” sempre capace di bilanciare tutti gli interessi in gioco, fornendo risposte adeguate ai diversi bisogni sociali (che sono anche quelli che nascono dal rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, compreso quello internazionalmente riconosciuto a essere protetti contro la persecuzione e, ovviamente, a non essere lasciati in mezzo a una strada mentre si esamina la domanda di protezione: del resto, si tratta di una concessione molto minore di quella che fu riservata ai nostri nonni emigrati, i quali vennero accolti come “migranti economici”).
Però, non si venga a dire che l’opzione del taglio secco delle spese per l’accoglienza sia una scelta necessaria, pragmatica, priva di alternative e che, dopo aver ceduto a questa forma di egoismo, potremo dormire serenamente la notte.
In primo luogo, non è necessario, e neppure morale mi viene da dire, alimentare la rabbia dei cittadini italiani indirizzandola contro le risorse stanziate per l’accoglienza quando viviamo in un Paese che brucia ogni anno 16 miliardi di euro in sprechi e inefficienze, così come ricordato il 4 febbraio scorso dal Centro Studi della CGIA di Mestre.
In secondo luogo, non è pragmatico lasciare le miriadi di persone che sbarcano nel nostro Paese all’avventura: allora sì che avremmo seri problemi di ordine pubblico. Inoltre, neppure è pragmatico dire “aiutiamoli a casa loro” se non siamo al contempo disposti a spendere laggiù, per infrastrutture civili e sociali, non meno di quanto spenderemmo qui.
In terzo luogo, è contraddittorio scegliere le vie semplicistiche, come quella di eliminare il servizio di accoglienza solo perché esso ha dato adito a fenomeni di corruttela, quando non chiederemmo mai la chiusura di altri servizi essenziali (come quelli ospedalieri) a fronte di consimili fenomeni (tra l’altro, economicamente assai più ingenti): infatti, quando un servizio non funziona, la soluzione (pratica) è intervenire sui difetti e non cancellarlo.
Tra l’altro, giusto l’obiettivo di assicurare che siano adeguatamente spesi, faccio altresì presente che i famosi 35 euro sono una partita di giro per gli italiani, perché vengono incamerati da enti nostrani nonché da personale e fornitori che ci lavorano: al pari di qualsiasi altro contratto pubblico (per cui, però, non assisto alle stesse levate di scudi).
Quindi, ben vengano le iniziative recentemente presentate da alcune forze politiche tese ad accrescere la trasparenza nelle rendicontazioni dei gestori dei centri di accoglienza (sebbene sul punto possano già giocare un ruolo importante le “clausole di legalità” inserite nei bandi delle Prefetture). Ma, soprattutto, ci si batta per dare piena attuazione alla famosa regola del 2,5 richiedenti per ogni mille abitanti, che è stata pensata per non far pesare troppo sulle singole comunità gli ospitati e, così facendo, migliorare anche le speranze di integrazione dei migranti: peraltro, affinché questa regola possa davvero dirsi rispettata e affinché possa con il tempo scomparire la logica emergenziale dei centri di accoglienza straordinaria (CAS), occorre abbandonare la retorica dei muri e delle palizzate, chiedendo semmai a tutti gli enti locali (del Paese) di condividere l’onere dell’ospitalità aderendo allo SPRAR (e ai connessi benefici). Se tutti lo faranno, si creeranno le condizioni per una gestione ordinata del fenomeno, non si renderanno più necessari fenomeni di ospitalità a sorpresa e, così, le singole comunità neppure si accorgeranno della presenza dei migranti.
Per dirla con Giddens, viviamo in un tempo che ci vede fronteggiare, “come individui e come umanità nel suo insieme”, sfide parzialmente inedite, prima tra tutte quella della Globalizzazione, intesa non solo e non tanto come accettazione di un “sistema mondo” che se ne sta là fuori, bensì, come fenomeno che si manifesta prima di tutto “qui dentro”, nella “vita locale”, perché è la nostra maggiore o minore propensione a relazionarci con quel mondo che determina il modo in cui sapremo conviverci. In questo contesto di smarrimento, così come rilevato in uno studio di P. Norris e R. Inglehart citato da Manuel Anselmi nel suo bel libro sui “Populismi”, è del tutto naturale che alcuni possano percepire alla stregua di una “minaccia” la cultura dell’apertura verso il mondo (c.d. “cosmopolitan liberalism), talvolta spregiativamente etichettata come intrisa di politically correct. Però, se quello che costoro chiamano “politically correct” è la “tolleranza sociale dei diversi stili di vita, delle religioni, delle culture, del multiculturalismo, del dialogo, della cooperazione internazionale, della governance democratica, della protezione delle libertà fondamentali e dei diritti umani”, ebbene, io mi iscrivo tra i “politicamente corretti”: perché quella appena citata non è né sinistra né destra (almeno una certa destra), ma è la moderna ricetta per la pace perpetua kantiana, e il fatto che non la si sia ancora realizzata non significa che l’obiettivo non sia più desiderabile.
E poi, francamente, è da “buonisti” difendere una consolidata tradizione, sociale e costituzionale, nata da secoli di lotte sanguinarie per la libertà e fatta di principi assai più alti e insieme più pragmatici di ogni inutile cinismo? Io non credo. Ma, in ogni caso, sempre meglio buonisti che cattivisti. Infatti, chi con troppa facilità si fa abbindolare dai nuovi populismi anti-immigrati, nazionali e locali, spesso neppure è in grado di ammettere che a guidarlo non è la ragione, bensì, solo una paura e un disprezzo primordiali verso l’altro-da-sé. Un altro-da-sé che quando arriva, il più delle volte, è maschio, alto e muscoloso, perché chi era debole e gracile, in molti casi, il viaggio non è riuscito a finirlo.