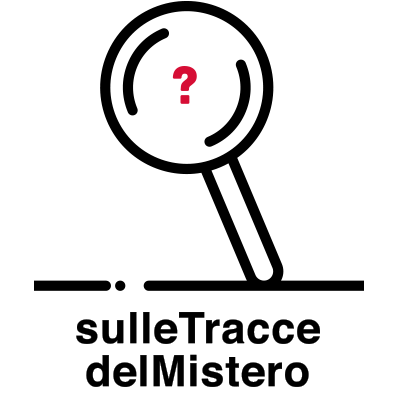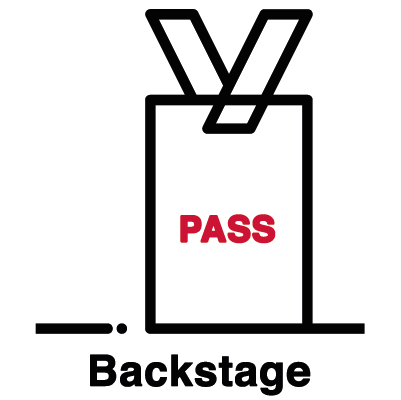Sgarbi: “Presentare Giotto a Sutri è riflettere sulle origini del linguaggio moderno nell’arte”
Homepage - SUTRI - "Giotto è un punto fermo, e ogni ritrovamento, ogni nuova acquisizione, è una festa per tutti, e ci parla dell’uomo e di come l’arte ce ne racconti il destino". Così Vittorio Sgarbi.

 SUTRI – Vittorio Sgarbi racconta la mostra di Palazzo Doebbing.
SUTRI – Vittorio Sgarbi racconta la mostra di Palazzo Doebbing.
Riprende, dopo una pausa più lunga del previsto, il ciclo delle mostre a Palazzo Doebbing di Sutri. Certamente una regia unica, e anche il desiderio del Sindaco, tra le mille difficoltà amministrative, di dare ai suoi concittadini tutto quello che, almeno nel campo dell’arte che, in Italia, e in uno dei suoi borghi più belli, è tema centrale e costituzionale, è possibile fare vedere in un palazzo che offre le migliori condizioni espositive in tutta la Tuscia.
Le incertezze, i limiti, gli inganni di molti sindaci rendono difficile se non impossibile l’impresa che, in una complessa composizione, si realizza a Sutri. Per me è un dovere ed è anche la ragione per la quale ho scelto di rianimare un luogo perfetto vicino a Roma con tutta l’abilità, l’esperienza e gli artifici del mio privilegiato mestiere. L’importante intervento nel Palazzo, che un tempo fu del vescovo, dell’architetto Romano Adolini, consente, a fianco delle sale destinate al museo d’arte sacra, di avere spazi versatili in cui con limitate dotazioni, e questa volta grazie all’intervento di Intesa Sanpaolo, si possono mettere in collisione esperienze artistiche lontane e diverse.
Non è mio compito né mia prerogativa l’ordinaria amministrazione, ma è mio orgoglio arricchire la città di iniziative altrimenti impossibili. La storia di Sutri, dopo la grande stagione etrusca e romana, è, per la sua posizione geografica,
sulla Cassia alla volta di Roma, storia di incursioni barbariche che la investono tra il V e il VIII secolo a.C.
Quando il papa capì le intenzioni dei Longobardi – i quali erano probabilmente intenzionati a conquistare la stessa Roma – si sentì minacciato, in quanto era preferibile l’autorità di un imperatore eretico ma lontano, piuttosto che quella di un energico sovrano vicino.
Nel 728 quindi Liutprando conquistò la città di Sutri e il suo castello dalle milizie bizantine e papa Gregorio II chiese e ottenne, con molto sforzo, di rinunciare ai territori già conquistati. Liutprando, invece di rinunciare a favore dei Bizantini (ai quali, secondo diritto, dovevano essere restituiti in quanto legittimi possessori) donò ai “beatissimi apostoli Pietro e Paolo” il castello di Sutri. La donazione aveva ad oggetto la cessione gratuita alla Chiesa di
Roma oltre che di Sutri, di alcuni castelli laziali (Bomarzo, Orte e Amelia). Nasceva così il Patrimonium Sancti Petri, primissimo nucleo del potere temporale della Chiesa, che sarebbe durato fino al 1870. Già nel 742, Liutprando aveva restituito al Pontefice (papa Zaccaria) per donationis titulo quattro città (tra cui Vetralla, Palestrina, Ninfa e Norma) da lui occupate e una parte dei patrimoni della Chiesa in Sabina, sottratti dai duchi di Spoleto oltre trent’anni prima.
Liutprando dal canto suo, aveva rilassato temporaneamente le tensioni con gli altri duchi longobardi, soprattutto dei ducati periferici e quindi più autonomi di Spoleto e Benevento, evitando una guerra civile. Storicamente, la donazione di Sutri sarebbe successiva alla Donazione di Costantino del 321, con cui l’imperatore Costantino I cedeva alla Chiesa di Papa Silvestro I sovranità sullo Stato della Chiesa, donando il palazzo del Laterano, i simboli imperiali e la città di Roma.
L’autenticità della donazione costantiniana venne tuttavia messa in discussione già nel XV secolo dall’umanista Lorenzo Valla, che ne dimostrò la falsità su base linguistica e filologica: essa sarebbe stata approntata, invece, tra l’VIII e il IX secolo. Il primo vero atto formale per la istituzione del Patrimonio di San Pietro sarebbe costituito, dunque, dalla Donazione di Sutri.
A conferma di questa tesi, ci sarebbe il fatto storico della nascita della Repubblica di San Pietro nell’VIII secolo, intesa non solo come “Stato dei Papi” ma anche come entità politica autonoma, dotata di proprie strutture di governo e di un territorio. Il ruolo comunque della donazione è stato ridimensionato, non essendo più considerato l’atto formale di nascita di un potere temporale papale; ma rispetto alle molteplici donazioni avvenute anche prima
del 728 a favore della Chiesa romana, va sottolineato che la donazione di Sutri acquista un valore simbolico notevole dato che ciò segna il riconoscimento di una sovranità che di fatto il papato esercitava sui territori romani, a discapito del governatore bizantino.
Va ricordato comunque che grandi problemi e difficoltà investono le questioni storiografiche relative alla nascita di uno Stato della Chiesa e del potere temporale del papato; e spesso divergenti sono le interpretazione che atti – come quello di Liutprando – hanno subito negli anni. Di questo momento cruciale per la storia di Sutri sono le lamine di ambito bizantino e longobardo presentate con la denominazione felice di “Petala aurea”, con riferimento alla loro fragilità e leggerezza, realizzate per decorare manufatti in legno, osso o avorio, cuoio, ma anche per essere cucite su tessuti, in particolare abiti cerimoniali e d’uso liturgico.
Una sezione è dedicata alle crocette, rinvenute all’interno di sepolture e dunque probabilmente cucite al sudario dei defunti attraverso i forellini presenti. Dal punto di vista iconografico, i pezzi in collezione presentano motivi geometrici e fitomorfi, in alcuni casi monogrammi, figure umane e animali, figure femminili e maschili viste di fronte.
Rinasce così davanti a noi sotto specie di lamine dorate, con immediatezza, nel presente, un mondo remoto che ci riporta a 1292 anni fa, quando, a Sutri, la chiesa fondò il suo potere temporale. Una inesausta passione ha indotto Luigi Rovati a cercare in quelle lamine frammenti di una storia remota: nella loro irregolarità nella loro asimmetria, nella loro fragilità, nelle loro ammaccature, nelle loro deformazioni, quelle “brattee” sono, letteralmente, foglie d’oro con la stessa leggerezza di foglie e petali animati da una imprevedibile vita.
In quelle lamine si manifesta una storia fatta di desideri e di sospiri per sempre perduti con gli abiti e gli oggetti che le sottili lamine adornavano. Questa storia lontanissima è la storia degli anonimi artigiani che plasmavano le forme nel pensiero di Dio. Ma da qui ci si sposta al momento in cui l’arte è espressione di individui che reinterpretano la storia divina attraverso la sensibilità degli uomini. La vita, la passione, il dolore sono la misura della umana
fragilità di Cristo e di sua madre, in una espressione di dolore tutto umano. Di questo ci parla Giotto nelle sue mirabili e umanissime immagini sacre. Un frammento ne vediamo, sullo scorcio del XIII secolo, nel dossale con la Vergine, al tempo del crocifisso di Santa Maria Novella, semplice e disarmata, e anche rassegnata, in una semplicità verginale, soprattutto nella forma ancora timida e acerba. Presto la Madonna assumerà una espressione intensa
e drammatica, come nella croce ritrovata della collezione Sgarbossa di Cittadella che testimonia una originale reinterpretazione del Crocifisso di San Felice in Piazza di Firenze.
Presentare Giotto a Sutri è riflettere sulle origini del linguaggio moderno nell’arte. Giotto è un punto fermo, e ogni ritrovamento, ogni nuova acquisizione, è una festa per tutti, e ci parla dell’uomo e di come l’arte ce ne racconti il destino. Tra le sorprese degli Incontri a Sutri, c’è un capolavoro dimenticato, il San Sebastiano curato da Irene di Gherardo delle Notti, sintesi di realismo caravaggesco e di luminismo arti!ciale. Insieme al pathos della circostanza, il virtuosismo del pittore è nella intuizione dell’ombra lunga proiettata dalla mano che si ripara dalla luce della candela, motore dell’effetto notte cui il pittore indulge negli anni compresi fra il 1613 e il 1618, tra il Gesù nella bottega di Giuseppe, il Cristo davanti a Caifa, e la Negazione di Pietro.
Gherardo intende specializzarsi in un clima luministico, non estremamente drammatico, ma molto suggestivo, ottenuto grazie agli effetti speciali della luce della candela. La stesura ha una ricercata morbidezza, senza
i forti contrasti di Ter Brugghen e di La Tour. Gherardo intende essere un pittore di emozioni, di forte intimismo, come nello scambio di sguardi tra le due donne. La luce carezza, non squarcia il buio. E Gherardo si conferma un regista di atmosfere.
Tornati all’aria aperta, la magni!cenza dei luoghi in una natura numinosa, e non lo si può intendere meglio che in Tuscia, e a Sutri in particolare, è il pensiero dominante di un tedesco che, negli anni di rinnovamento delle arti promosso a Roma da Antonio Canova, giunse in Italia: Franz Ludwig Catel. La comunità tedesca a Roma è rappresentata dai Nazareni che, per primi, provarono entusiasmo per i primitivi italiani e li reinterpretarono. Catel denuncia emozioni primarie: nessuna più intensa di quella che viene dal paesaggio. La luce che trasferisce l’incanto e
l’incantesimo diffusi sulla natura è quella che oggi vedete sull’an!teatro di pietra, sulla necropoli, sulla valle della Cassia, la stessa luce che ha diffuso Catel nei suoi paesaggi deserti abitati da un Dio misterioso. “Et in Arcadia ego”: è questo avvertimento tragico che ci conduce da Catel a Kantor.
Io Kantor l’ho conosciuto e gli ho lungamente parlato, dopo essere stato travolto, sopraffatto, da La classe morta vista a Milano. Un viaggio nell’abisso e un passaggio agli inferi, ma carico di una umanità che si porta dietro la propria infanzia, come scriveva Baudelaire:
“i verdi paradisi degli amori infantili,
le corse, le canzoni, i baci, i fiori offerti,
i violini vibranti dietro le colline,
con le brocche di vino, la sera, nei boschetti.”
La domanda è:
“ma il verde paradiso degli amori infantili,
il paradiso innocente dai piaceri furtivi,
è già più lontano dell’India o della Cina?
Si può richiamare con grida piangenti
e popolarlo ancora di voci argentine,
il paradiso innocente dai piaceri furtivi?”
Kantor non ha dubbi, nel suo ricordo: “Io sono nato il 6 aprile 1915 in Polonia in un paesino con una piazza del mercato e qualche vicoletto squallido. Sulla piazza del mercato si innalzavano una piccola cappella con la statua d’un santo, secondo l’uso cattolico, e un pozzo attorno al quale si celebravano, al chiaro di luna, le nozze ebraiche. Da una parte una chiesa, un presbiterio e un cimitero, dall’altra una sinagoga, delle tortuose straducole ebree
e ancora un cimitero, ma un cimitero differente.
Le due comunità vivevano in perfetta armonia. Cerimonie cattoliche spettacolari, processioni, bandiere, costumi folclorici a vivaci colori, contadini. Dall’altra parte preghiere, berretti di volpe, candelabri, rabbini, pianti
della piazza del mercato, riti misteriosi, canti fanatici e bambini. Aldilà della vita quotidiana questo borgo silenzioso era del tutto dedito al culto dell’eternità. Naturalmente c’erano un medico, un farmacista, un istitutore, un curato, un capo della polizia. La moda era quella di prima della guerra (la prima guerra mondiale). Lasciando alle spalle la piazza principale ci s’inoltrava verso i campi di frumento, le colline, subito dopo c’erano le foreste e piú lontano
ancora, da qualche parte, una ferrovia. Mio padre, insegnante, non è ritornato dalla guerra. Mia madre, mia sorella e io siamo andati a vivere dal fratello di mia nonna che era curato.
È là che siamo stati allevati. Ecco da dove mi deriva l’immagine del presbiterio. La chiesa, assistere allo spettacolo. Per Natale si preparava in chiesa un presepe con diverse statuine, per Pasqua una grotta con quinte decorate, dove stavano in piedi dei veri pompieri con caschi d’oro. Io imitavo tutto questo in dimensioni ridotte. Avevo confuso il teatro con la ferrovia che avevo visto, la prima volta, dopo aver fatto un lungo viaggio in braeck. Con scatole da scarpe vuote ho costruito varie scene. Ogni scatola formava una scena diversa.
Le legavo con una corda come se fossero vagoni. Poi le facevo passare attraverso un grande cartone con un’apertura (che si potrebbe dire scenica): cosí ottenevo dei cambiamenti di scena. A mio giudizio questo fu il mio più grande successo in teatro”. Ecco La classe morta.
L’infanzia che ritorna come un’ossessione, per esorcizzare la morte, in una paura che deriva dal tempo ineluttabile. Kantor esibisce la morte nel suo teatro, in un difficile rapporto tra l’uomo e il potere. E Kantor lo dichiara: “Sai, non sono assolutamente un freddo, un astratto, mai. Quando lo ero nel senso attribuito a questo termine dall’arte informale, il mio atteggiamento era sempre qualcosa di molto partecipato. Io sono contro la combinazione, il calcolo, la pseudo-scienza, l’arte che si difende a furia di definizioni scienti!che. Ci sono molti artisti che agiscono con metodi ‘scienti!ci’ del tutto inesistenti!… L’arte deve essere del tutto nuda, disarmata”. È ancora Kantor che sostiene: “Sono contro l’espressionismo perché in fondo io sono espressionista. So che l’espressionismo conduce all’estremo, vale a dire alla !ne dell’arte”. La sua opera è legata alla fine. Dalla negazione della speranza deriva una idea nuova
dell’uomo. Tutta l’opera di Kantor è un dialogo con la realtà, ma nella realtà degradata c’è già un approccio alla morte. La classe morta non è che un incontro con la morte. Sul piano dell’arte, della vita. Ma l’arte non potrebbe essere che vitale. La classe morta non è tragica.
Nella tensione fra grottesco e tenerezza “traduce l’aspirazione a una vita piena e totale che abbracci il passato, il presente e l’avvenire”. Ma segna anche un momento decisivo nell’evoluzione dell’artista: quello in cui il manichino, già usato in Santa Giovanna, ne La Gallinella acquatica, ne I Calzolai, “oggetto vuoto” e “messaggio di morte”, diventa un modello per l’attore vivente. Un modello, ma non un sostituto. Il momento in cui Kantor scopre che solo
l’assenza di vita permette di esprimere la vita; in cui immagina, momento rivoluzionario fra tutti, l’apparizione dell’attore: “Di fronte a quelli che stavano da questa parte, un uomo si è alzato del tutto simile a ognuno di loro e purtuttavia (in virtú di qualche ‘operazione’ misteriosa e ammirabile), infinitamente lontano, terribilmente estraneo, come abitato dalla morte, separato da loro da una barriera che pur essendo invisibile non sembrava meno spaventosa e inconcepibile, e il cui senso vero e l’orrore possono esserci rivelati solo dal sogno… Come nella luce accecante di un lampo, scorgono all’improvviso l’Immagine dell’uomo, sgradevole, tragicamente clownesca, come se la vedessero per la prima volta, come se ritornassero dall’aver visto se stessi”.
Frasi estratte dal Teatro della morte: un manifesto. La classe morta: uno spettacolo. Nell’uno e nell’altro caso un doppio confronto, faccia a faccia. Fra Kantor e noi. Fra la Morte e l’attore. Questo attore, dice Kantor, “lo vedo piuttosto come un ribelle, un obiettore, un eretico, libero e tragico, per avere osato restare solo con la sua sorte e il suo destino”. Questo ribelle è solamente l’attore? Non potrebbe magari essere Kantor o il modello che si è dato, non
esitando a tuffarsi nella meta!sica del concreto per affermare la realtà del teatro?…
Per Kantor il teatro è “un luogo dove le leggi dell’arte si incontrano con la causalità della vita”. È in questo punto che si può trovare una convergenza tra l’esperienza della morte nel teatro di Kantor e l’esperienza della morte nella vita di Pasolini. Le fotografie di Dino Pedriali ci mettono di fronte all’ultimo tempo di Pasolini, in un testamento del corpo celebrato nella casa di Chia, la torre acquistata da Pasolini come sua ultima dimora fuori dal mondo, in un teatro della vita.
È estremamente significativo che, negli ultimi giorni di vita, Pasolini, insieme alla meditazione sulle “Confessioni” di Sant’Agostino (che legge nell’edizione dei Millenni Einaudi), ritorni a pensare al maestro degli anni universitari, Roberto Longhi, che, attraverso l’incoraggiamento di Francesco Arcangeli, lo aveva folgorato con le sue lezioni sull’arte italiana, in particolare su Masaccio e Caravaggio, pilastri della sua poetica neorealista.
Pasolini si era misurato anche con la pittura e, in quei giorni di ottobre del 1975, nella torre di Chia, aveva ripreso a disegnare il volto del maestro attraverso una celebre fotografia ripetutamente tradotta a china su grandi fogli bianchi. Il pensiero rivolto a Longhi è l’estrema testimonianza di una costante rimeditazione sull’arte figurativa cui, nei suoi film, era tornato, con compiaciute citazioni da Giotto a Pontormo. Arcangeli avrebbe riassunto
la lezione di Roberto Longhi sulla grande arte padana, culminante in Caravaggio (vera ossessione per Pasolini, nei suoi “ragazzi di vita”, quasi un transfert), con le parole: “corpo, azione, sentimento, fantasia”. Il “corpo fisico” era stato il tormento e l’estasi di Pasolini, come lo è, nella più alta tradizione del culto del nudo classico da Winckelmann a Canova, per Mapplethorpe e Dino Pedriali. Una fisicità incombente, esaltante: un vero e proprio “corpo sacro”.
Pedriali fu immediatamente consapevole che il suo compito era salvare il corpo di Pier Paolo Pasolini, il corpo intatto prima che fosse sfigurato da una terribile violenza. A indicare la connessione fra i manichini di Kantor e il corpo morto di Pasolini è la scultura dolorosa come un crocifisso, estraneo alla passione di Cristo, di Cesare Inzerillo. Si tratta, in entrambi i casi, di esperienze mistiche.
La decomposizione dei corpi, per una rigenerata “classe morta”, è nostalgia di una bellezza perduta; e in ciò si misura il dialogo di Inzerillo con uno scultore vitalistico come Livio Scarpella. Nessuna resurrezione è possibile se non nello spazio della memoria. Il corpo intatto, la bellezza come aspirazione estrema, in Livio Scarpella, sono stranei a ogni idealismo, e così immediatamente umani da liberare la scultura da quel senso di morte che sempre l’accompagna. La scultura sublima la morte ma la conferma.
Scarpella aspira a doppiare la vita, a trasferirla nel marmo, nel bronzo o nella terracotta con una palpitante immediatezza, con una verità !sica; e riesce a rianimare la ritrattistica realistica della scultura romana in mirabili ritratti maschili. In una inedita congiunzione fra stile greco arcaico e Pop art, realizza una sorprendentemente viva Patty-Kore ispirata a Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, la cui canzone Ragazzo triste fu la mia colonna
in collegio, adolescente inquieto, dieci anni prima che La classe morta di Kantor diventasse il mantra della mia giovinezza. Alla morte e alla storia riconsegna l’armonia della bellezza Alessio Deli. Alla concezione classica rinascimentale, dal modello della Eleonora d’Aragona di Francesco Laurana, l’attualizzazione delle maschere antigas non aggiunge niente, non muta il destino di morte. Alessio Deli ha nostalgia di un mondo perduto, e non vorrebbe il
presente cui è costretto. Anche il classicismo è una forma della morte. Lo contraddice, nella materia, nella vibrante ceramica, ancora calda del fuoco che la cuoce, l’esperienza di Mirna Manni che sembra voler riportare l’uomo alla natura. Mentre Chiara Caselli lo accompagna con il nitore della sua visione fotografica sofisticata e rarefatta, misurandosi con spazi assoluti tra cielo e mare, in una metafora fotografica dell’in!nito, con singolari affinità con
le vedute di Piero Guccione.
E intensamente lirici sono gli interni con luci soffuse a proteggere, con discrezione, l’indiscrezione del voyer che ruba momenti di intimità. La sensibilità della Caselli è distaccata e insieme morbosa, voluttuosa e frigida, chiara e imperturbabile. Chiara, come i grandi interpreti, cerca il segreto delle cose. “Tendono alla chiarità le cose oscure
si esauriscono i corpi in un “uiredi tinte: queste in musiche. Svanire è dunque la ventura delle venture”, aveva anticipato Montale.
Per converso, le vedute o i ritagli di vedute di Massimo Rossetti sono la memoria ansiosa di un genere perduto che sopravvive per frammenti. Secondo la figura retorica che, in linguistica, si chiama sineddoche: il tutto è evocato da una parte. Ciò che nell’intero poteva risultare illustrativo, come un’immagine da cartolina, ritagliato assume una universalità carica di senso. I dettagli del Duomo di Cremona o dell’Arco di Costantino non sono indiziari
ma probatori. La Madonna di Marco Romano a Cremona, nella spericolata inclinazione, esercita lo sguardo, assolvendolo da una ricognizione esatta. Si tratta di un’equivalente contemporaneo de l’école du regard o nouveau roman il cui obiettivo era una ossessione.
Alla rappresentazione coerente dell’uomo e del mondo il nouveau roman sostituì la presenza ossessiva degli oggetti: ecco Massimo Rossetti. Chiude il ciclo di mostre un inglese che si è da qualche anno ritirato a Civita Castellana,
Justin Bradshaw, artista sorprendente. Pittore paziente e ispirato, Justin si muove negli spazi ristretti del suo studio nella sua casa, insieme a quelli scon!nati della sua mente. Estremo pittore della realtà, Justin vede negli oggetti d’uso quotidiano degli assoluti sensuali (non concettuali), concedendosi a un virtuosismo estremo ma non compiaciuto. Vuole stupire. Nel suo realismo non è certo fotografico, ma denso, noumenico, identificativo, essenziale
nella descrizione degli oggetti. Nei ritratti e negli autoritratti è quasi inevitabile il riferimento a Lucian Freud. In!ne, nel travestimento in abiti contemporanei del Banchetto di Erode, con formidabile immediatezza, si muove in un genere gravido di soluzioni sorprendenti, in parallelo con le esperienze italiane di Rocco Normanno e di Giovanni Gasparro. Potremmo evocare in queste interpretazioni la categoria metastoriografica di “neorealisti”, che ci porta
direttamente all’ultima pagina degli Incontri a Sutri. Le Storie della vita di Caravaggio raccontate da Guido Venanzoni.
Si tratta di episodi essenziali della biografia di Caravaggio, illustrati con spirito manzoniano. È un gusto narrativo ottocentesco, con la descrizione di ambienti e caratteri creati con una suggestione descrittiva che nasce in un cenacolo di caravaggisti di cui fu dominus il compianto, e amico del pittore, Vincenzo Pacelli. Venanzoni lavora come lo scenografo e il costumista di un film su Caravaggio, con maniacale attenzione al dettaglio in un racconto evocativo con momenti essenziali, come la formazione con Simone Peterzano; la frequentazione di osterie e prostitute a Roma; la riflessione e il confronto nello studio del Cavalier d’Arpino; lo spettacolo per la decollazione di Beatrice Cenci; l’assassinio di Ranuccio Tomassoni; l’arresto a Palo laziale; e infine la morte.
Sequenze di un film con l’identi!cazione di Venanzoni in Caravaggio. Abbiamo visto, nella pittura, la storia di alcuni
episodi della vita di Giotto o di Leonardo. E anche Raffaello, Michelangelo e Tiziano sono stati il soggetto di pittori che hanno raccontato momenti essenziali della vita, e quello fatale, nel genere del lamento, della morte. Per nessun artista ricordo un ciclo così ampio e, tanto meno, per un pittore maledetto come Caravaggio. La ricostruzione di Venanzoni è filologica e insieme pittoresca, non romanzata e neppure letteraria, dal momento che abbiamo fonti,
in particolare Giovanni Baglione, molto puntuali sulla vita avventurosa di Caravaggio.
Così la pittura di Venanzoni obbedisce più alla passione che all’aneddoto ed è insieme un atto d’amore e un atto critico. Certamente, per chi verrà a Sutri, un’esperienza originale.