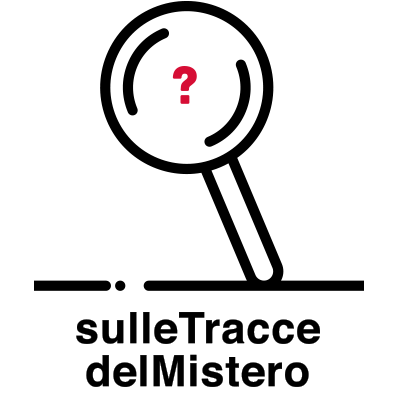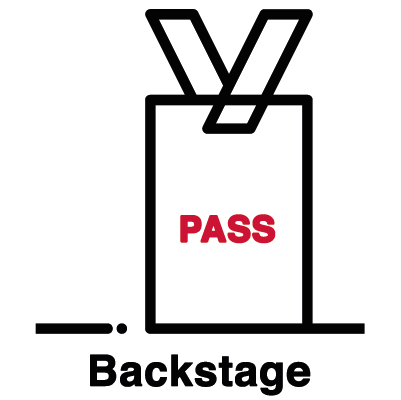Il Sestante – Il 25 aprile, la democrazia e le ferite di un Paese
Homepage - E poi, dopo tutto questo tempo, dovremmo aver capito che quei partigiani che si sono sacrificati per noi, evidentemente, lo hanno fatto proprio perché la Costituzione possa essere accettata da tutti per la sua intrinseca bontà, e mai più scritta con il sangue.
Poche ricorrenze hanno la capacità di unire e dividere il nostro Paese come il 25 Aprile. Molti pensano sia solo una “festa” e nemmeno si rendono conto che tipo di “festa” sia. In proposito, ricordo uno sconfortante servizio televisivo di qualche tempo fa in cui, alla domanda su che cosa significasse il 25 Aprile, molti neppure sapevano che cosa vi si celebrasse.
Eppure, fu quello il giorno in cui al grido di “arrendersi o perire!” la Resistenza si sollevò a Milano e nell’Italia Settentrionale, segnando così uno degli ultimi capitoli dell’occupazione nazi-fascista del nostro Paese. Si trattò di un momento autenticamente fondante per le sorti d’Italia perché segnò molto più che il ripudio di un recente passato dominato dalla dittatura: simbolicamente, fu il giorno in cui l’idea di Resistenza all’oppressione, da sempre presente nelle riflessioni di molti filosofi e nell’esperienza dei patrioti di ogni parte del mondo, divenne, anche nel nostro Paese martoriato, forza consapevole di sé nella Storia.
Ma in un senso diverso da quello delle lotte risorgimentali. Infatti, stavolta, non si trattava di far emergere una nuova Nazione fra le Nazioni, bensì, di riscattare un popolo dal giogo di una tirannia che lo aveva avvelenato dal suo stesso interno. Pertanto, non sorprende che si fu in presenza di un risveglio traumatico, violento e bagnato dal sangue di vincitori e vinti.
Certo, gli eredi ideologici del mondo uscito sconfitto da quella stagione osservano che la Storia incorona sempre chi trionfa, mentre condanna all’oblio lo sconfitto, che spesso neppure si vede riconosciuta la pietà che normalmente si tributa ai defunti. Invece, sul versante opposto, alcuni di quelli che si rispecchiano nel lascito della Resistenza, facendo leva sulla dimensione dei valori, liquidano come sterilmente rancorose le critiche di chi difende dei criminali (come testimoniano gli innumerevoli eccidi perpetrati dagli occupanti e dai loro collaborazionisti), e poi, facendo leva su una sorta di meccanicismo storico, minimizzano i crimini di guerra perpetrati anche da alcune realtà partigiane (come se fossero state l’inevitabile, naturale e legittima reazione a un crimine precedente).
Ora, io credo che entrambe le posizioni siano portatrici di una parte della verità. Comunque, dico subito che la tesi secondo cui “la storia la fanno i vincitori” mi sembra spendibile solo fino a un certo punto: intanto, perché mi sembra un tipo di argomentazione che, subdolamente e illogicamente, induce a pensare che chi perde avrebbe sempre ragione; inoltre, perché ciascuno di noi, oggi, ha gli strumenti per valutare il male intrinseco di certe azioni umane.
Per intenderci, instaurare un sistema di governo che privi un popolo del diritto di esprimersi liberamente e senza il timore di subire violenza a causa di un dissenso, per me, è obiettivamente ingiusto. Inoltre, considerato che prima dell’avvento del Fascismo quelle libertà si erano già affermate, forse, il vero denigratore dei valori patrii è stato chi ha inteso cancellare quelle libertà.
D’altro canto, bisogna anche fare i conti con certi partigiani da aperitivo i quali, lungi dall’aver vissuto quella stagione, adesso tendono, con il senno di poi, a trasformare un giudizio storico verso un fenomeno certamente deteriore (il nazi-fascismo) in una specie di fatwa da lanciare contro la memoria di tutti quelli che perirono credendo di combattere dalla parte giusta della Storia. E penso in questo senso alla miglior metafora che credo sia mai stata fatta per rappresentare quei giovani che morirono “dalla parte sbagliata”: il Cuoco di Salò di De Gregori.
A ben vedere, uno dei maggiori problemi di questo Paese, ieri come oggi, è quello di faticare a convergere su una memoria condivisa. Ad una giornata che potrebbe e dovrebbe servire per riunirci tutti attorno a un ideale, nel segno della Liberazione dalla tirannia, anche quest’anno, in molti arriveranno divisi, incapaci perfino di parlarsi o stringersi la mano. Come se a dominare le loro esistenze non fosse la loro volontà, ma piuttosto i demoni di un odio incancrenito che è sopravvissuto alle generazioni che lo hanno generato.
Un odio che ancora avvelena le coscienze e che, a volte, ci fa prendere una posizione più per opposizione a un supposto nemico che non per reale accettazione di quella posizione. Eppure, il lascito di quel periodo, per tutti noi, è davvero immenso: infatti, la stagione della Resistenza coincise con l’avvio di una fase costituente in cui vennero riscoperte, e ulteriormente perfezionate, tutte quelle libertà che avevano progressivamente visto la luce nell’Italia post-unitaria: questo, grazie all’approvazione della Costituzione.
In proposito, mi vengono in mente alcuni scritti nei quali Zagrebelsky elogia la grandezza delle moderne forme di governo occidentali perché, appunto, esse non sono solo delle mere “democrazie”, ossia dei sistemi di potere in cui la maggioranza governa, bensì, delle democrazie “costituzionali”, ossia basate su un patto fondamentale (la Costituzione) stretto fra tutte le forze sociali di un Paese: un patto attraverso cui le forze anzidette si accordano su un nucleo indissolubile di valori e principi (di libertà e di uguaglianza) che nessuna maggioranza dovrà mai pregiudicare.
Infatti, se così non fosse, si aprirebbe la via alla c.d. dittatura della maggioranza, perché chiunque conquistasse il potere, inevitabilmente, non incontrerebbe limiti nel corso del suo mandato. E così, a soffrirne, sarebbero ovviamente le minoranze, che rischierebbero di essere perseguitate da un potere democratico non così dissimile da un potere antidemocratico.
Insomma, un sistema così concepito, mette al centro le ragioni di tutti: in primo luogo, quelle delle maggioranze, che si tutelano con la forza dei numeri, con cui approvano le leggi e determinano gli indirizzi destinati a determinare le sorti del Paese (seppur “nelle forme e nei limiti” dettati dalla Costituzione); in secondo luogo, le ragioni delle minoranze, che vengono tutelate non dalla legge del più forte, bensì, dalla forza di un grande principio. Un principio di civiltà, umana e giuridica, che a noi sembra quasi scontato, tanto che neppure ci accorgiamo della sua operatività: come per la salute, ci rendiamo conto di quanto importante essa sia solo quando la perdiamo. Non a caso, proprio quel principio è ancora fortemente avvertito nel mondo, specie in quei contesti dove l’idea di una società basata sul reciproco rispetto rappresenta ancora una chimera.
In tal senso, mi torna in mente la lettera di una ragazza afghana che il Corriere della Sera pubblicò alcuni anni fa, in occasione delle prime libere elezioni tenutesi nel Paese dopo il crollo del regime dei Talebani: in quell’occasione, la giovane ripercorreva le sue vicissitudini familiari, raccontando della fuga all’estero, del dolore derivante dal fatto di aver vissuto da esule e, infine, la gioia di poter tornare tra le sue valli e tra la sua gente per far sapere al mondo che, grazie a quel voto, le era stata ridata la dignità.
La dignità che deriva dal poter dire “io voto”, quindi “io esisto” e ho la “stessa dignità” di tutti gli altri perché chi governa deve “ascoltarmi”. Certo, sappiamo che l’Afghanistan è ancora lontana dal realizzare il sogno racchiuso in quella lettera e, per certi versi, ci siamo persuasi che il periodo delle guerre per l’esportazione della democrazia potrebbe essere ricordato come un fallimento storico: l’atto di forza di una civiltà, la nostra, di imporre alle altre i propri modelli valoriali e di governo (in questo caso, la democrazia). Eppure, quella lettera sta ancora là, consegnando alla storia anche la versione di chi nella democrazia dell’eguale dignità fra tutti continua a credere, pur appartenendo ad un mondo diverso da quello occidentale.
A dispetto di ogni confine, terrestre e culturale, la vicenda di questa ragazza ci dimostra che, con ogni probabilità, certe idee non appartengono del tutto al retaggio delle società che le hanno partorite ma sono destinate, prima o poi, ad imporsi per razionalità e forza attrattiva loro propria. Chissà, magari sarà così anche per la democrazia costituzionale.
D’altro canto, se questo può essere vero fra culture tanto distanti, perché disperare che, un domani, non possa avvenire qualcosa di simile anche nel nostro Paese? Se impareremo a celebrare questo giorno di Liberazione dalla tirannia sapendo anche perdonare la memoria di chi, senza partecipare a eccidi, non ebbe altra colpa che schierarsi “dalla parte sbagliata”, probabilmente, riusciremo a superare quel lutto nazionale che ci portiamo dietro dagli anni Quaranta.
Un lutto mai del tutto elaborato e che, ancora oggi, impedisce agli eredi delle forze sociali che non parteciparono al processo costituente di riconoscere la bontà della nostra democrazia costituzionale.
Calamandrei diceva che, se vogliamo conoscere davvero la Costituzione, non dobbiamo andare a cercarla in un bel tomo tenuto nelle biblioteche o nei Palazzi del Governo, ma nei boschi e sulle montagne dove coloro che morirono per donarcela versarono il loro sangue. Ma quel sangue aveva lo stesso colore di quello dei loro nemici. Pertanto, io mi chiedo se non sia venuto il momento di usare i nostri valori come una forza di attrazione per chi fino ad oggi li ha respinti, piuttosto che come un motivo per emarginarlo. Sarà difficile, ma non certamente impossibile. E poi, dopo tutto questo tempo, dovremmo aver capito che quei partigiani che si sono sacrificati per noi, evidentemente, lo hanno fatto proprio perché la Costituzione possa essere accettata da tutti per la sua intrinseca bontà, e mai più scritta con il sangue.