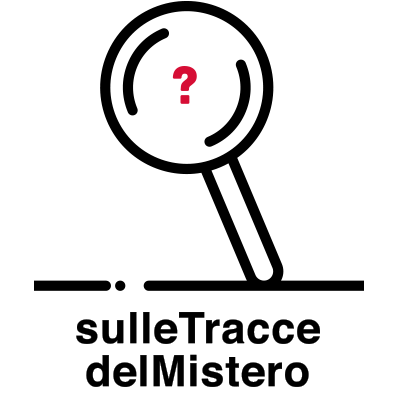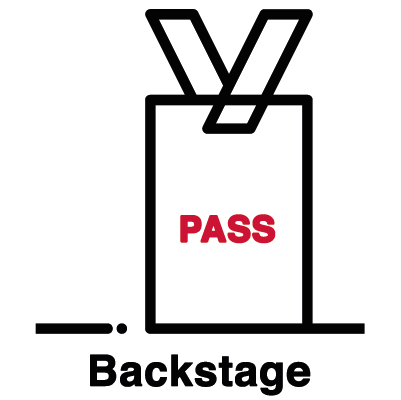Il Sestante – Dove va la politica italiana?
Homepage - Alle soglie della recente tornata per le amministrative, Ilvo Diammanti su Repubblica ricordava che in Italia “tutte le elezioni” hanno significato "politico nazionale" e che il voto negli oltre 1000 comuni italiani avrebbe rappresentato il più importante test per le forze politiche dopo il referendum costituzionale del 4 dicembre scorso.
Dove va la politica italiana all’indomani delle consultazioni per il referendum costituzionale e per le recenti amministrative?
Alle soglie della recente tornata per le amministrative, Ilvo Diammanti su Repubblica ricordava che in Italia “tutte le elezioni” hanno significato “politico nazionale” e che il voto negli oltre 1000 comuni italiani avrebbe rappresentato il più importante test per le forze politiche dopo il referendum costituzionale del 4 dicembre scorso. E infatti, a ben vedere, è solo dall’analisi congiunta di questi due importanti momenti elettorali della recente storia politico-amministrativa del nostro Paese che possono venire indicazioni utili anche per i futuri assetti del mondo dei partiti.
Ora, che il suffragio referendario sia stato un voto pro o contro Renzi, e molto poco basato sul merito del progetto di riforma, mi pare fuori questione. E lo dico anche se avrei preferito che quella riforma fosse stata avversata per ragioni tecniche, dato che, al pari di quella del centrodestra del 2005, non credo proprio che avrebbe reso più efficiente la nostra forma di governo. Comunque, il voto del 4 dicembre è stato importante in ogni caso per almeno due buoni motivi.
In primo luogo, perché ha tuonato contro una prassi assai deteriore della politica italiana degli ultimi anni, ossia quella di prendersela con le regole fondamentali per attribuire a fattori esotici (in questo caso la Costituzione) la responsabilità di problemi che sono tutti interni al mondo politico. In secondo luogo, perché ha espresso un moto di condanna nei confronti della “politica leaderistica”, ossia quella dove il capo della coalizione di governo tende a personalizzare ogni riforma come se “emanasse” da lui stesso e non dalle mediazioni tra le varie anime espresse in Parlamento (le quali incarnano, o almeno dovrebbero incarnare, le diverse anime ideali del Paese).
Ebbene, quale può essere la lezione che ci consegna la vicenda del voto del 4 dicembre? Fondamentalmente, che è finita l’era delle scuse. Infatti, se all’indomani di una vittoria elettorale i partiti non riusciranno a mettere in piedi coalizioni in grado di governare, d’ora in poi, dovranno smettere di dire che è colpa della Costituzione piuttosto che della scarsa coesione e dei trasformismi interni.
Del resto, proprio questi fattori critici sono agevolati dalla circostanza che non ci si raccoglie quasi mai intorno a un’idea, bensì, a un leader, e quando il consenso del leader scema, comincia il fuggi fuggi proprio perché non c’è una netta distinzione ideologica tra gli appartenenti alle varie forze (una distinzione, insomma, che impedisca ai singoli di giustificare i loro abbandoni). Pertanto, in un simile scenario, non sorprende che finiscano con il rivelarsi inutili anche le leggi elettorali più inclini a favorire maggioranze teoricamente stabili (come insegna la storia del premio di maggioranza fornito dal “porcellum”, che, dopo aver consegnato al IV Governo Berlusconi la più grande maggioranza della storia repubblicana, non impedì che lo stesso Berlusconi venisse defenestrato nel novembre 2011 dalla nuova schiera di fautori di Monti).
Quindi, ben venga la disfatta renziana del 4 dicembre scorso se, una volta definitivamente metabolizzata, porterà le forze politiche nazionali a comprendere che, senza cercare ulteriori scuse, esse devono cambiare in loro stesse tornando a essere chiaramente distinguibili e alternative sulla base di precise impostazioni programmatiche che prescindano dalla figura del leader (che pure resterà in ogni caso importante quanto meno perché dovrà infondere alla coalizione di cui si porrà a capo la necessaria autorevolezza).
Detto questo, le recenti amministrative sono andate in questa direzione? A un primo sguardo sembrerebbe di sì, perché analizzando la sostanziale vittoria del centrodestra sembra che gli elettori abbiano premiato la scelta “ri-unificatrice” di quello che era uno dei due poli tradizionali, tornato così più chiaramente distinguibile rispetto allo schieramento simul-democristiano in salsa renziana. Inoltre, questo ha portato anche a un vistoso arretramento di quel terzo polo comparso negli ultimi anni, incarnato dal M5S, che aveva trovato la sua forza proprio grazie alla capacità di occupare un vuoto lasciato dai precedenti due poli nella fase in cui operavano più alla rinfusa.
D’altro canto, sarebbe ingenuo da parte dei sostenitori degli schieramenti della Seconda Repubblica utilizzare già adesso toni trionfalistici: infatti, i mali recenti della politica sono ancora tutti endemici, a cominciare dalle contraddizioni interne della coalizione di centrodestra, che oscilla tra il sostanziale europeismo di Berlusconi e l’euroscetticismo di Lega e FDI, ma senza dimenticare neppure le cicatrici interne ai DEM e agli ex DEM, ancora alle prese con le recenti scissioni che pongono una seria questione sull’identità del centrosinistra non meno di quanto ancora lo sia quella sull’identità del centrodestra. Inoltre, sebbene con alcuni distinguo, parliamo ancora di forze politiche che somigliano più a comitati elettorali per i rispettivi leader che non a veri partiti: una deriva, questa, che è tanto più inedita se guardiamo in casa di una forza, il PD, che tradizionalmente era stata quella più impermeabile a questo modo di fare politica.
In definitiva, quindi, a me pare che dopo le recenti Amministrative si possa salutare con prudente favore il ritorno a una parziale logica della democrazia dell’alternanza fra schieramenti contrapposti che siano chiaramente distinguibili. Però, a patto di portare a compimento questo processo di rinascita partendo dall’acquisita consapevolezza degli errori del passato. Pertanto, il passo successivo dovrà essere quello della riduzione del tasso di dipendenza dalla figura carismatica del leader (che spesso è anzi un ostacolo all’allargamento della base elettorale se, al di fuori della cerchia dei fedelissimi, gli altri potenziali elettori scelgono pregiudizialmente di non votare la forza politica di cui è a capo solo per ragioni di antipatia personale).
Ebbene, questo salto di qualità, visto che proprio le comunali hanno dato il là, potrebbe nascere dal maggiore attivismo delle forze politiche locali, che dovranno organizzare occasioni di incontro, siano esse nell’ambito di centri studi, assemblee periferiche o incontri a tu per tu con i cittadini, per ridare alla politica più prossima alla gente quell’autorevolezza e quell’incisività di cui è stata privata dall’abbandono delle preferenze a livello nazionale. Se le comunità politiche locali si renderanno più autonome e al contempo indispensabili per i loro leader, non solo contribuiranno a bilanciare lo squilibrio oggi esistente tra centro e periferia, ma costringeranno la politica nazionale ad aprirsi davvero a quella democrazia interna di cui parlava l’Art. 49 della Costituzione, dando anche vita a partiti esponenziali di idee e valori che non siano solo quelli personali del leader. E, magari, temperando gli eccessi delle varie anime presenti nelle singole coalizioni, queste nuove forze torneranno a parlare a quell’Italia che non ama le urla, che pretende serietà e che oggi, con il voto per disperazione o con l’astensione, fa la fortuna dei populismi.